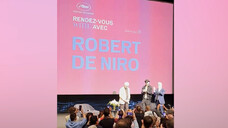(di Paolo Petroni)
'La banalità del male', il celebre
discusso saggio di Hannah Arendt nato dal processo Eichmann, non
è quella relativa ai crimini nella Shoah dell'imputato ma quella
della normalità e passività sua e dei tanti tedeschi che vi
presero parte; 'La banalità dell'amore', titolo dell'avvincente
testo di Savyon Liebrecht, che torna in scena con la regia di
Piero Maccarinelli al Teatro India sino al 18 maggio, è quella
della passività e irrazionalità di questo sentimento specie in
un rapporto non simmetrico, non paritario.
In questo caso si tratta di quello, nella Germania che vive
la crisi di Weimar e l'ascesa del nazionalsocialismo, tra il
trentacinquenne professor Martin Heidegger e appunto Hannah
Arendt, sua alunna ebrea diciottenne, che scopriremo sentirsi un
giorno praticamente plagiata e di aver vissuto con tutta se
stessa quell'amore che le creò sofferenza e solitudine per
l'affascinante autore de 'L'essere e il nulla', che aprì la
strada alla filosofia moderna non vedendo più il filosofo come
un soggetto che osserva la realtà, ma - semplificando - come un
soggetto coinvolto nell'oggetto.
Hannah è la protagonista del lavoro costruito con
intelligenza e messo in scena con la sapienza della regia nello
sfruttare il lato spettacolare dei due piani temporali e
logistici in cui tutto si svolge. Abbiamo, da una parte della
scena, Arendt anziana in America che accetta di essere
intervistata da un giovane studente dell'Università di
Gerusalemme, anche per chiarire la sua posizione e il senso dei
suoi scritti travisati e attaccati con durezza a suo tempo,
specie in Israele. E dall'altra lei giovane in Germania e il suo
incontro e gli anni di grande amore col professore, sposato e
con due figli, che la ringrazia per aver accettato di restare in
disparte e per la felicità che gli dona, dicendole: "Non potrei
immaginare la mia vita senza di te, senza parlarti, senza
vederti, senza toccarti. Tu sei parte di me".
In fondo alla scena, di Carlo De Marino, due porte diverse,
poste dalla regia, a creare un bell'intreccio, inversamente alle
due situazioni temporali, servono alle entrate di Heidegger e
dell'amico e compagno di studi Raphael Mendelsohn, proprietario
della casa in cui i due si incontrano, innamorato di lei e
sempre respinto. Due porte che si aprono sul passato e sul
presente di Arendt che, col passare del tempo, si sente sempre
più divisa tra il non rinnegare quello che comunque fu il più
grande, vero amore della sua vita, e assieme condannare
inesorabilmente l'uomo che aderisce al nazismo per diventare
rettore dell'Università, credendo in un Hitler che avrebbe
riportato agli antichi fasti lo spirito e la cultura tedeschi,
escludendo dall'università persino il suo maestro Husserl,
accettando passivamente le feroci regole antiebraiche, che
faranno poi finire Anna in prigione e, subito dopo, a emigrare
nel Stati Uniti.
Lo spettacolo presenta con il giusto ritmo gli incontri
d'amore tra lei e il professore e poi l'ultimo, nel 1974, quando
Arendt torna in visita in Germania e si rifiuta soffrendo di
testimoniare a favore dell'uomo davanti alla Commissione per la
denazificazione, alternandoli con sapienza scenica, con quelli
tra lei e il giovane venuto a intervistarla, che sarà il
protagonista di un colpo di scena quasi giallo, che condurrà
alle intense considerazioni finali, esaltando la dimensione più
umana e struggente e dolorosa di una sorta di resa dei conti di
una vita, inevitabilmente sempre impigliata nel suo passato.
Una umanità coinvolgente per le sfumature, l'agitazione e il
temperamento che le dà la brava Anita Bartolucci e la luminosità
e trepida inquietudine di lei giovane proposta dall'ottima
Mersila Sokoli, ben definite anche dai costumi di Zaira de
Vincentiis, cui si intrecciano la sapienza, il sentimento e
l'ingenua, esaltata ambiguità dell'Heidegger di un
credibilissimo Claudio Di Palma e la doppia parte cui dona
verità Giulio Pranno.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA