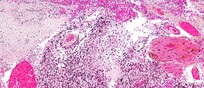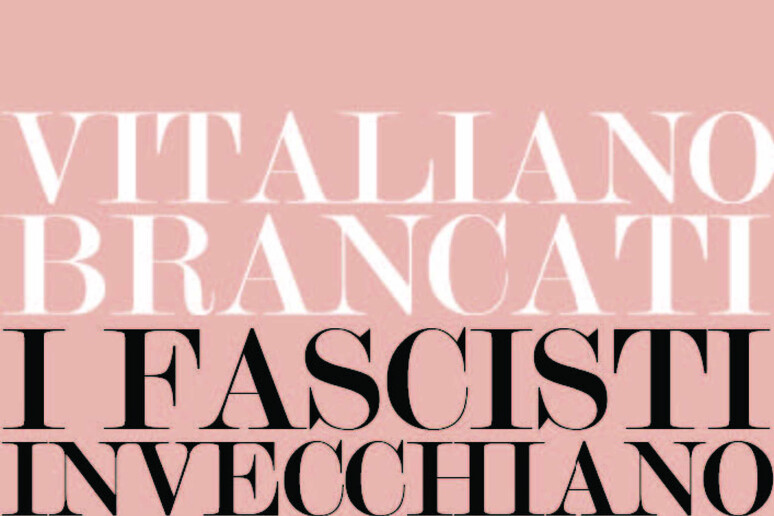La retorica vuota e mortifera del regime di Benito Mussolini, gli strilli della propaganda, la violenza cieca e colpevole della guerra, l'antifascismo "invecchiato", "illanguidito" e amareggiato "dall'abitudine all'insuccesso", e ancora il servilismo di chi dichiarava di "non fare politica" e "lavorare per dare il pane ai propri figli" mentre si inchinava di fronte ai gendarmi. Ha un passo provocatorio, beffardo e dissacrante la scrittura di Vitaliano Brancati nei testi che compongono la raccolta de "I fascisti invecchiano", in libreria con Elliot.
A metà tra il saggio e la narrativa, nel solco stilistico e tematico dei romanzi, gli otto scritti presenti nel libro (che venne pubblicato per la prima volta nel 1946 da Longanesi) scattano una fotografia perfetta del regime e del popolo italiano durante il Ventennio. Brancati si mostra impietoso pur mantenendo un approccio comico, e osserva con gli occhi dell'intellettuale acuto e disincantato la dittatura che si era appena conclusa. Lo fa prendendo di mira le simbologie (dalle teste rasate agli stivaloni e alle camicie nere, dagli annunci roboanti per impressionare le folle al culto della virilità) e cristallizzando sulla pagina scritta alcuni comportamenti tipici degli italiani del tempo, tra debolezze, vigliaccherie e fragilità, i cui echi arrivano fino a oggi.
E non risparmia un'analisi tanto puntuale quanto amara: "Qualcuno obietterà che bisognava opporre l'eroismo vero a un eroismo falso, il sacrificio estremo per una causa profondamente giusta al sacrificio estremo per una causa sedicente giusta.
Questo è accaduto dopo", scrive nel volumetto, "Ma fra il '36 e il '43, le condizioni morali e mentali erano così basse, le coscienze così disposte a ingannarsi, le voci della menzogna così numerose e assordati che le divise dei veri e dei falsi eroi si sarebbero confuse". Ma, se è forte la vis satirica nei confronti della società, Brancati è altrettanto duro anche verso se stesso. Anche lui infatti all'inizio fu infatuato da Mussolini e organico al regime ("il fascismo lo reputai una religione", scrive). "Quel credere non si sa bene a che cosa...
era un gradevolissimo e sicuro antidoto del pensiero: quel credere si risolveva in sostanza nel categorico invito a non pensare", scrive quasi confessandosi l'autore siciliano, consegnando al lettore pagine godibili e dense di significato, capaci ancora oggi di parlare al presente.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA